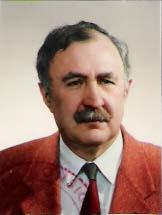Verso la metà degli anni Cinquanta, quando Vanni cominciò a frequentare i giardini Ghidini di Corso Gabetti, anche noi abbandonammo il nostro ritrovo di largo Moncalvo per approdare ai giardini Ghidini. Giorgio, Giancarlo, Gino, io e qualche volta anche Adolfo prendemmo l’abitudine di trovarci sulle panchine del giardino dove ci unimmo ad altri ragazzi del borgo, naif come noi: Adriano (Saruja), Tale (l’Americano), Dino (il Corvo), Carlin (Mus), Peru, Bob, Ciano, suo fratello Guido e Aldo (Barulin, il mio compagno di banco delle elementari), oltre a Paolo (Bulugnin, diventato poi l’ultimo e celebre fabbro di Borgo Po) ed altri di cui ho dimenticato i nomi ma non i volti. Anche qualche amica frequentava con noi i giardini: ricordo Enza, Rosanna, Luciana, Franca e Carla.
Come ritrovo invernale, ci insediammo al “Piollino”, bar di Via Moncalvo angolo Via Santorre di Santarosa, ora oculario, quasi di fronte alle suore tedesche (le uniche che in tempo di guerra ebbero il privilegio di conservare intatta la cancellata in ferro, altrimenti requisita per essere riciclata in cannoni per la patria). Più avanti, per incompatibilità con il figlio del proprietario del Piollino, decidemmo di trasferirci tutti quanti al Bar Natale di Piazza Borromini, proprio di fronte alle famose cantine Risso, dove si andava a mangiare i pesci del Po.
Divenne un nostro grande amico Adriano, che lavorava nell’azienda paterna con suo fratello e sua sorella, nel settore dei recuperi metallici, con la sede in Via Sciolze (l’azienda esiste tuttora ed è stata trasformata da Adriano e i suoi in falegnameria e fai-da-te).
Adriano, che fu uno dei primi a prendere la patente, dopo la vespa si comperò la Fiat 500 C.
Ricordo ancora un viaggio in camion con lui, sino a Venezia e ritorno, con sosta all’autogrill Pavesi di Novara, che credo essere stato il primo grill costruito in Italia.
Ci si fermava a bere il cappuccino spruzzato al cioccolato che era una novità per quei tempi.
La felicità era raggiunta quando suo fratello gli prestava la Fiat 1400 che in quei tempi era una vettura di assoluto prestigio. Ci sentivamo veramente dei signori quando, sprofondati nei sedili dell’auto, andavamo in giro il più delle volte senza una meta precisa.
Con noi c’era sempre anche Giancarlo Bertolero, già nostro compagno delle elementari, figlio unico, appassionato di motori, che frequentò la scuola per motoristi Biraghi di Corso Novara.
Diplomatosi, andò ad aiutare suo padre che aveva iniziato una fiorente attività nel settore degli ammortizzatori per auto, la BETOR.
Con Giancarlo B. conobbi il mondo delle risaie, perché la nonna paterna abitava in un paesino del vercellese di nome Ronsecco e che noi, nel nostro girovagare con la moto andavamo ogni tanto a trovare anche per conoscere le mondine del luogo, che erano quasi tutte della nostra età.
Ci trovavamo a casa di Giancarlo a giocare a carte: Adriano, Giorgio, Giancarlo Chiapello, io, lui e la cugina dell’ospite, Marisa.
La mattina del giorno dopo l’Epifania del 1959 mi trovavo sul filobus che da Piazza Statuto portava a Rivoli per recarmi al lavoro presso la sede staccata della Westinghouse di Regina Margherita, quando buttai l’occhio su “La Stampa” del vicino di viaggio. Rimasi di sasso vedendo la foto di un’auto distrutta con la didascalia “l’auto del Bertolero”. Scesi e andai subito a comprarmi il giornale e appresi così che il nostro amico Giancarlo a soli 20 anni, la sera dell’Epifania si era schiantato contro un palo a bordo della Lancia Appia di suo papà sulla tangenziale di Corso Polonia.
Gli era toccato il triste record di essere il primo morto sulla tangenziale che era stata appena costruita in vista delle celebrazioni di Italia ’61.
Quella morte ci colpì molto, ricordo ancora il funerale, dove noi amici portammo il feretro a turno sulle spalle e il dolore inconsolabile e tremendo dei suoi genitori.
Mi fece molto male apprendere in seguito che gente accorsa al momento dell’incidente dalla bidonville esistente allora in Corso Polonia si era appropriata del suo cappotto e del suo orologio.
La nostra Torino stava già cambiando e purtroppo non in meglio, anche se il peggio del degrado morale doveva ancora arrivare.